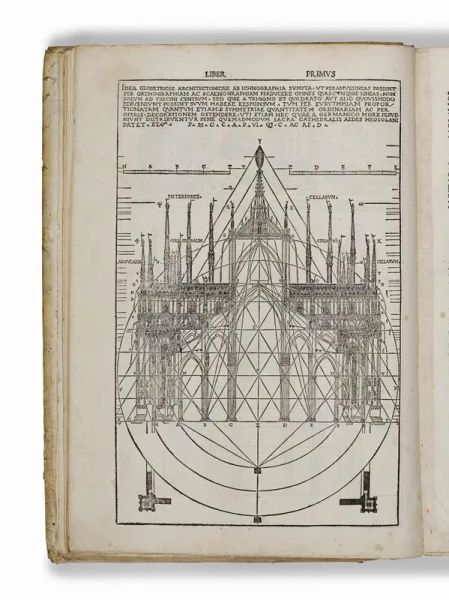1
- 13
di 13 LOTTI
1
Giovanni della Robbia
Giovanni della Robbia
(Firenze 1469 - 1529/1530)
STEMMA E IMPRESA DELLA FAMIGLIA BARTOLINI (BARTOLINI [..]
1
Offerta Libera
Giovanni della Robbia
Giovanni della Robbia
(Firenze 1469 - 1529/1530)
STEMMA E IMPRESA DELLA FAMIGLIA BARTOLINI (BARTOLINI [..]
Stima
€ 100.000 / 150.000
Aggiudicazione
2
PIATTO, URBINO, FRANCESCO XANTO AVELLI, 1537
PIATTO URBINO, FRANCESCO XANTO AVELLI, 1537
maiolica dipinta in policromia con verde in due toni, [..]
2
Offerta Libera
PIATTO, URBINO, FRANCESCO XANTO AVELLI, 1537
PIATTO URBINO, FRANCESCO XANTO AVELLI, 1537
maiolica dipinta in policromia con verde in due toni, [..]
Stima
€ 70.000 / 100.000
3
COPPA, FAENZA, BALDASSARRE MANARA O BOTTEGA, 1540 CIRCA
COPPA FAENZA, BALDASSARRE MANARA O BOTTEGA, 1540 CIRCA
Maiolica dipinta in policromia con arancio, giallo [..]
3
Offerta Libera
COPPA, FAENZA, BALDASSARRE MANARA O BOTTEGA, 1540 CIRCA
COPPA FAENZA, BALDASSARRE MANARA O BOTTEGA, 1540 CIRCA
Maiolica dipinta in policromia con arancio, giallo [..]
Stima
€ 70.000 / 100.000
4
COPPA, URBINO, NELLA CERCHIA DI FRANCESCO XANTO AVELLI, PITTORE “LU UR” (“L”), LUSTRATO A GUBBIO O A URBINO (“N”), 1535
COPPA URBINO, NELLA CERCHIA DI FRANCESCO XANTO AVELLI, PITTORE “LU UR” (“L”), LUSTRATO [..]
4
Offerta Libera
COPPA, URBINO, NELLA CERCHIA DI FRANCESCO XANTO AVELLI, PITTORE “LU UR” (“L”), LUSTRATO A GUBBIO O A [..]
COPPA URBINO, NELLA CERCHIA DI FRANCESCO XANTO AVELLI, PITTORE “LU UR” (“L”), LUSTRATO [..]
Stima
€ 30.000 / 50.000
Aggiudicazione
5
Marco Vitruvio Pollione
Marco Vitruvio Pollione (70-80 a.C. ca. – dopo il 15 a.C. ca.) Cesare Cesariano (1483 – [..]
5
Offerta Libera
Marco Vitruvio Pollione
Marco Vitruvio Pollione (70-80 a.C. ca. – dopo il 15 a.C. ca.) Cesare Cesariano (1483 – [..]
Stima
€ 10.000 / 15.000
Aggiudicazione
6
FIRENZE, FERDINANDO I DE’ MEDICI, DOPPIA DA DUE O SCUDO QUADRUPLO, 1591
FIRENZE, FERDINANDO I DE’ MEDICI, DOPPIA DA DUE O SCUDO QUADRUPLO, 1591
Oro 22 carati, gr. [..]
6
Offerta Libera
FIRENZE, FERDINANDO I DE’ MEDICI, DOPPIA DA DUE O SCUDO QUADRUPLO, 1591
FIRENZE, FERDINANDO I DE’ MEDICI, DOPPIA DA DUE O SCUDO QUADRUPLO, 1591
Oro 22 carati, gr. [..]
Stima
€ 40.000 / 60.000
7
CASSETTONE A RIBALTA CON ALZATA, VENEZIA, METÀ SECOLO XVIII
CASSETTONE A RIBALTA CON ALZATA VENEZIA, METÀ SECOLO XVIII
lastronato in legno di noce e radica [..]
7
Offerta Libera
CASSETTONE A RIBALTA CON ALZATA, VENEZIA, METÀ SECOLO XVIII
CASSETTONE A RIBALTA CON ALZATA VENEZIA, METÀ SECOLO XVIII
lastronato in legno di noce e radica [..]
Stima
€ 80.000 / 120.000
8
COPPIA DI CONSOLES CON SPECCHIERA, NAPOLI, FINE SECOLO XVIII
COPPIA DI CONSOLES CON SPECCHIERA NAPOLI, FINE SECOLO XVIII
legno intagliato, dipinto e dorato, [..]
8
Offerta Libera
COPPIA DI CONSOLES CON SPECCHIERA, NAPOLI, FINE SECOLO XVIII
COPPIA DI CONSOLES CON SPECCHIERA NAPOLI, FINE SECOLO XVIII
legno intagliato, dipinto e dorato, [..]
Stima
€ 120.000 / 180.000
9
Filippo Carlini
Filippo Carlini
(attivo intorno alla metà del secolo XVIII)
STUDIO DEL MOSAICO AL VATICANO, [..]
9
Offerta Libera
Filippo Carlini
Filippo Carlini
(attivo intorno alla metà del secolo XVIII)
STUDIO DEL MOSAICO AL VATICANO, [..]
Stima
€ 120.000 / 180.000
10
CRONOGRAFO DA POLSO IN ACCIAIO, ROLEX, REF. 6263, FONDELLO REF. 6239, CASSA N. 2'085'533, COSMOGRAPH DAYTONA, QUADRANTE 'PAUL NEWMAN PANDA', 1969 CIRCA
RARO CRONOGRAFO DA POLSO IN ACCIAIO, ROLEX, REF. 6263, FONDELLO REF. 6239, CASSA N. 2'085'533, COSMOGRAPH [..]
10
Offerta Libera
CRONOGRAFO DA POLSO IN ACCIAIO, ROLEX, REF. 6263, FONDELLO REF. 6239, CASSA N. 2'085'533, COSMOGRAPH [..]
RARO CRONOGRAFO DA POLSO IN ACCIAIO, ROLEX, REF. 6263, FONDELLO REF. 6239, CASSA N. 2'085'533, COSMOGRAPH [..]
Stima
€ 150.000 / 250.000
Aggiudicazione
11
COLLANA, INIZI XIX SECOLO, IN DIAMANTI, ARGENTO E ORO BIANCO
COLLANA, INIZI XIX SECOLO IN DIAMANTI, ARGENTO E ORO BIANCO
realizzata ad una linea di trentasette [..]
11
Offerta Libera
COLLANA, INIZI XIX SECOLO, IN DIAMANTI, ARGENTO E ORO BIANCO
COLLANA, INIZI XIX SECOLO IN DIAMANTI, ARGENTO E ORO BIANCO
realizzata ad una linea di trentasette [..]
Stima
€ 220.000 / 300.000
Aggiudicazione
12
Luca Giordano
Luca Giordano
(Napoli 1634 – 1705)
APOLLO E MARSIA
olio su tela, cm 125x180 [..]
Trattativa privata
Aggiudicazione
13
Ruggero Panerai
Ruggero Panerai
(Firenze 1862 - Parigi 1923)
RITORNO DALLE CORSE ALLE CASCINE
olio su tela, [..]
13
Offerta Libera
Ruggero Panerai
Ruggero Panerai
(Firenze 1862 - Parigi 1923)
RITORNO DALLE CORSE ALLE CASCINE
olio su tela, [..]
Stima
€ 150.000 / 200.000
1
- 13
di 13 LOTTI

![CRONOGRAFO DA POLSO IN ACCIAIO, ROLEX, REF. 6263, FONDELLO REF. 6239, CASSA N. 2'085'533, COSMOGRAPH [..]](https://images.pandolfini.it/@img/_large/b288bda6e3aeedf79be7ec7964b2ff0f857ba73a.webp/-cronografo-da-polso-in-acciaio-rolex-ref-6263-.webp)